“Intangible Capital” di Mary Adams e Michael Oleksak
28/05/2011 Lascia un commento
Ho di recente terminato la lettura del libro di Mary Adams e Michael Oleksak “Intangible Capital – Putting knowledge to work in the 21-st Century Organization” edito da Praeger (2010), a questo link trovate il sito ufficiale. In qualche post precedente vi avevo già dato un’anticipazione sul loro metodo di rappresentare le imprese con il Lego, un modo innovativo per utilizzare i famosi mattoncini. Nel libro, ovviamente, non c’è solo questo, anzi la trattazione del tema intangibles è molto ampia e propone alcuni spunti davvero innovativi.
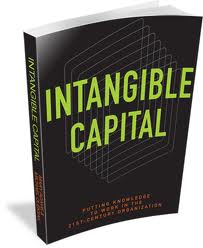 La prima parte di “Intangible Capital” si occupa dell’introduzione al mondo degli intangibles, descrivendone la loro natura. Adams ed Oleksak adottano la classica tripartizione capitale umano, capitale relazionale e capitale strutturale, aggiungendo però quella che loro definiscono “business recipe”, ossia la traduzione degli intangibles in un modello di impresa funzionante. In sostanza questo quarto elemento sarebbe il “collante” dei tre componenti del capitale intellettuale che gli conferisce un fine utile. A mio avviso questa parte è la meno interessante del libro (se si eccettua la sezione dedicata Lego), forse anche perché non sono affatto nuovo la letture di questo genere e possiamo dire che non aggiunge molto a quanto già proposto da numerosi autori, come Lev, Sveiby e Stewart. Apro una piccola parentesi: se mi è consentito muovere una critica, spesso quando molti autori parlano della tripartizione del capitale intellettuale e soprattutto si occupano di descrivere quei fenomeni riconducibili alle dinamiche della conoscenza e dell’apprendimento, lo fanno senza avere un valido supporto teorico alle spalle, per cui il risultato sono dei concetti che non hanno fondamenta solide e che possono essere soggetti a critiche (per inciso non sono un grande estimatore della “tripartizione” come potete leggere da un precedente articolo del blog). Quando parlo di terreno solido mi riferisco ad esempio alle teorie del knowledge management di Nonaka e Takeuchi, Davenport e Prusack, ma anche al filone di studi delle organizational capabilities, tra cui Nelson e Winter, Kogut e Zander, magari ne parlerò in un futuro articolo del blog.
La prima parte di “Intangible Capital” si occupa dell’introduzione al mondo degli intangibles, descrivendone la loro natura. Adams ed Oleksak adottano la classica tripartizione capitale umano, capitale relazionale e capitale strutturale, aggiungendo però quella che loro definiscono “business recipe”, ossia la traduzione degli intangibles in un modello di impresa funzionante. In sostanza questo quarto elemento sarebbe il “collante” dei tre componenti del capitale intellettuale che gli conferisce un fine utile. A mio avviso questa parte è la meno interessante del libro (se si eccettua la sezione dedicata Lego), forse anche perché non sono affatto nuovo la letture di questo genere e possiamo dire che non aggiunge molto a quanto già proposto da numerosi autori, come Lev, Sveiby e Stewart. Apro una piccola parentesi: se mi è consentito muovere una critica, spesso quando molti autori parlano della tripartizione del capitale intellettuale e soprattutto si occupano di descrivere quei fenomeni riconducibili alle dinamiche della conoscenza e dell’apprendimento, lo fanno senza avere un valido supporto teorico alle spalle, per cui il risultato sono dei concetti che non hanno fondamenta solide e che possono essere soggetti a critiche (per inciso non sono un grande estimatore della “tripartizione” come potete leggere da un precedente articolo del blog). Quando parlo di terreno solido mi riferisco ad esempio alle teorie del knowledge management di Nonaka e Takeuchi, Davenport e Prusack, ma anche al filone di studi delle organizational capabilities, tra cui Nelson e Winter, Kogut e Zander, magari ne parlerò in un futuro articolo del blog.
La seconda parte del libro, invece, si occupa di definire quali siano le “nuove” dinamiche organizzative di una “knowledge based firm”, anche in questo caso non ci sono grosse novità o meglio, se volete approfondire l’argomento la letteratura che potete trovare è ampia e molto più esaustiva di quanto riportato qui. Nonostante ciò ci sono elementi comunque interessanti, il focus degli autori viene posto sull’ “orchestrazione”, ossia sulla trasposizione all’interno dell’azienda della figura del direttore d’orchestra, che, non essendo un virtuoso di tutti gli strumenti, non può (e non dovrebbe) scendere troppo nei dettagli di ogni singolo musicista. Allo stesso modo dovrebbe comportarsi il manager del 21° secolo.
Nonostante la prima parte del libro sostanzialmente non riporti molte novità e la seconda aggiunga solo qualche elemento interessante, la terza fornisce invece concetti importanti come modello di “new accounting”, la nuova contabilità degli intangibles:
- i-capex
- Intangible assessment
- Performance Measurement
L’idea si concretizza quindi in tre elementi, la prima relativa all’ “i-capex” (i – capital expenditure), fa riferimento agli investimenti (in termini monetari) in intangible assets, ciò che consigliano gli autori è di tenere traccia di tutte le spese riconducibili ad investimenti in capitale intellettuale, a loro avviso questo è l’unico modo per fornire misurazioni di tipo monetario del fenomeno che abbiano un utilità, sia per chi è chiamato alla gestione aziendale, ma anche per gli altri stakeholder dell’impresa.
Il secondo caposaldo è rappresentato invece dall’ ”Intangible Assessment” del capitale intellettuale, definito letteralmente “the new Balance Sheet” (il nuovo stato patrimoniale), quello che suggeriscono Adams ed Oleksak è di redigere indagini periodiche sugli intangibles, sottoponendo adeguati questionari a tutti gli stakeholder aziendali, in questo modo dovrebbe essere possibile raccogliere informazioni sullo status quo dell’impresa rispetto ai diversi elementi del capitale intellettuale. Il terzo elemento è rappresentato infine dalla misurazione della performance (identificata come il nuovo conto economico) che dovrebbe contenere indicatori riferibili alle tre categorie di asset intangibili e ad avere un focus sia operativo che strategico, offrendo così una panoramica dinamica su quanto è accaduto (o sta accadendo) agli intangibles dell’impresa. Un accento particolare viene posto sulla “triangolazione” tra questi tre metodi di monitoraggio degli intangibles, che non vanno visti come sistemi a sé stanti, ma che al contrario dovrebbero proprio essere utilizzati in contemporanea per sfruttare le diverse prospettive con cui guardano al problema. In questo modo dovrebbe essere possibile avere un quadro completo sulla situazione aziendale che permetta di prendere decisioni consapevoli anche in materia di asset intangibili.
Un ulteriore capitolo è dedicato alla reputazione, aspetto non trattato dagli autori “classici” degli intangibles, ma che è diventato di estrema attualità negli ultimi tempi, basti pensare alle conseguenze negative che possono avere comportamenti che minaccino l’integrità dell’ambiente o la salute della popolazione. Se a tutto ciò uniamo la potenza di internet e dei social network, ci rendiamo conto come un solo errore possa avere ripercussioni enormi (direi anche fatali) sulla performance e sulla sopravvivenza di un’aziendale.
Il capitolo finale del libro fa una considerazione riguardo la diffusione della cultura degli intangibles nelle aziende e nelle istituzioni che ho trovato molto importante. Adams ed Oleksak, pur apprezzando le diverse iniziative nate con lo scopo di diffondere la cultura ed armonizzare il reporting sugli asset intangibili, sottolineano come il cambiamento debba partire dal basso, dalle aziende stesse ed anzi dai manager che non possono fare a meno di accorgersi quanto cruciale sia gestire e misurare gli asset intangibili.
Per concludere la lettura del libro è consigliata, come già detto in precedenza, la seconda e terza parte sono, a mio avviso, più interessanti della prima. Per chi fosse interessato ad acquistare il libro io l’ho trovato qui.
A presto!
Simone





 Click per accedere al file Excel
Click per accedere al file Excel
