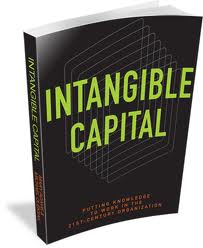La visione più classica del capitale intellettuale, proposta originariamente da Saint-Onge e riproposta poi da altri autori, è, come già detto nel post di apertura del blog, la tripartizione capitale umano, capitale clienti e capitale strutturale (per essere precisi inizialmente il capitale clienti faceva parte del capitale strutturale).

Numerosi autori hanno trattato di capitale intellettuale utilizzando questa classificazione, alcuni hanno apportato leggere modifiche, ma sostanzialmente questo è il modello che si è maggiormente diffuso su larga scala con applicazioni di diverso genere. C’è chi ha redatto bilanci degli intangibili secondo questi principi (in Italia ad esempio Brembo) e c’è chi ha proposto scorecard e sistemi di reporting (come ad esempio Sveiby).
Se ci soffermiamo ad analizzare approfonditamente i tre elementi, leggendo con attenzione le definizioni degli autori e osservando i metodi di misurazione che sono nati in base a questa tripartizione, possiamo notare come i confini tra un elemento e l’altro non siano poi così netti come ci potremmo immaginare. Mi viene soprattutto in mente una definizione fornita da Stewart (1997, Intellectual capital: the new wealth, Doubleday/Currency, New York – traduzione italiana, 1999, Il capitale intellettuale: la nuova ricchezza, Ponte alle grazie, Varese) riguardo il capitale strutturale che più o meno recita così: “il capitale strutturale è tutto ciò che rimane in azienda quando le persone sono andate a casa”, oppure anche Sveiby (1997, The new organizational wealth, Berrett- Koehler, San Francisco) che definisce capitale strutturale “l’organizzazione”.
L’affermarsi di questa visione, che in un certo qual senso offre una possibilità di spiegazione del fenomeno intangibles abbastanza intuibile e di facile comprensione, ha forse portato a trascurare un po’ la parte definitoria, che a mio avviso necessiterebbe di una teoria fondante più sostanziosa.
Naturalmente, come abbiamo già più volte detto, le teorie che si sono occupate di asset intangibili sono molteplici ed il fatto che non sia possibile definire gli asset intangibili secondo dei canoni standardizzati ha minato la diffusione di sistemi di misurazione standard ed ha favorito la proliferazione di tutti quei metodi che abbiamo visto in un precedente articolo pubblicato qui.
Detto questo però, non dobbiamo scordarci che anche se non esiste una teoria universale, ciò non significa che gli intangibles non siano importanti! Anzi, è proprio qui la sfida!
Abbiamo una certezza a cui agganciarci: la differenza tra valore di mercato e valore contabile di un’impresa è spiegata proprio dagli asset intangibili.
Tornando quindi ai metodi di rappresentazione degli intangibles e del capitale intellettuale, vorrei sottoporvi il lavoro di Contractor (2000, Valuing corporate knowledge and intangible assets: some general principles, Knowledge and Process Management, Vol. 7, Nr. 4, 242-255), che propone una visione che parte da presupposti un po’ diversi e che ci offre una lettura maggiormente dinamica rispetto alla famosa tripartizione che oramai ben conoscete.

Fonte: rielaborazione da Contractor (2000)
Come potete vedere dalla figura gli intangibles vengono anche in questo caso suddivisi in tre categorie, ma in questo caso sono rappresentati come sottoinsiemi l’uno dell’altro. Un approccio di questo genere sottolinea come gli asset intangibili abbiano natura unitaria e confini molto labili per i quali sia difficile un’identificazione certa.
La discriminante che determina il confine tra un sottoinsieme e l’altro è rappresentata dalla codificazione/esplicitazione della conoscenza e dalla sua eventuale registrazione come proprietà intellettuale. Troviamo così l’insieme più grande rappresentato dalla conoscenza tacita, insita negli individui ed incorporata nell’organizzazione, all’interno del quale trovano posto gli asset intellettuali codificati, come ad esempio le procedure, i progetti e i database. In questo caso possiamo parlare di conoscenza reificata, incorporata in alcuni “oggetti”, il valore di tali oggetti però è strettamente legato alla base di conoscenza tacita dei loro creatori/utilizzatori. Un esempio? Un database che raccoglie i dati dei clienti avrà un contenuto informativo diverso a seconda di chi vi acceda. Il customer service sarà in grado di estrapolare una mole rilevante di informazioni, utili per il proprio lavoro quotidiano, mentre gli stessi dati, osservati ad esempio da un addetto al controllo di gestione avranno una rilevanza minore e per certe parti risulteranno addirittura inutili. Come già affermato da Davenport e Prusack (1998, Working Knowledge, Harvard Business School Press) “ La conoscenza è nell’occhio di guarda!”
Infine nell’insieme più piccolo troviamo quella parte di sapere che oltre ad essere stato codificato e reificato in un oggetto “tangibile” (passatemi il termine), può godere dei diritti di tutela della proprietà intellettuale, l’esempio più lampante sono i brevetti. Un brevetto infatti, può essere visto come il punto di arrivo di dinamiche molto più intricate che hanno radici profonde nelle persone e nell’organizzazione. In altre parole il brevetto in se non è che la punta dell’iceberg del sapere di un’organizzazione.
Giungendo ora all’aspetto misurazione, come già preannunciato nella figura riportata sopra, gli asset intangibili legati alla conoscenza tacita, come è ovvio immaginare, sono quelli più difficili da misurare, mentre per i marchi ed i brevetti è più facile arrivare ad una valutazione di tipo monetario, tant’è che sono iscrivibili a bilancio come immobilizzazioni immateriali.
Spero che questo modello non vi abbia confuso le idee, rispetto alla classica tripartizione forse è un modo alternativo di guardare agli intangibles (non rappresenta necessariamente una via migliore), ma racchiude in se la spiegazione di molte dinamiche relative alla conoscenza che spesso vengono trascurate quando si parla di asset intangibili e di capitale intellettuale.
Simone
 edia per una definizione esaustiva), mai come ora è necessario il cambiamento e se non siamo noi a generare il cambiamento chi altri lo deve fare? La promessa per il 2012 (che ovviamente riguarda anche me stesso) è quella di aumentare il nostro impegno sociale nella politica e nella partecipazione a tutto ciò che ci riguarda, non è sempre e solo colpa dei nostri tanto odiati politici ma è anche colpa nostra se le cose vanno male, non aspettiamo che il cambiamento arrivi, perché se non ci muoviamo non arriverà mai! Per dirla con le parole di Albert Einstein: “non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose!”. Per cui in quest’anno appena iniziato, perché non facciamo qualcosa che non abbiamo mai provato a fare? Imponiamocelo! Prendiamo parte di più alla vita pubblica, partecipiamo a dibattiti, incontri; informiamoci, conosciamoci, discutiamo e organizziamoci! Nessuno di voi è mai andato ad assistere ad una seduta del consiglio comunale? Si può iniziare semplicemente da qui.
edia per una definizione esaustiva), mai come ora è necessario il cambiamento e se non siamo noi a generare il cambiamento chi altri lo deve fare? La promessa per il 2012 (che ovviamente riguarda anche me stesso) è quella di aumentare il nostro impegno sociale nella politica e nella partecipazione a tutto ciò che ci riguarda, non è sempre e solo colpa dei nostri tanto odiati politici ma è anche colpa nostra se le cose vanno male, non aspettiamo che il cambiamento arrivi, perché se non ci muoviamo non arriverà mai! Per dirla con le parole di Albert Einstein: “non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose!”. Per cui in quest’anno appena iniziato, perché non facciamo qualcosa che non abbiamo mai provato a fare? Imponiamocelo! Prendiamo parte di più alla vita pubblica, partecipiamo a dibattiti, incontri; informiamoci, conosciamoci, discutiamo e organizziamoci! Nessuno di voi è mai andato ad assistere ad una seduta del consiglio comunale? Si può iniziare semplicemente da qui.